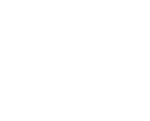Prima volta su Moodle@Units?
Leggi le Guide a Moodle per sapere come usare Moodle@Units:
Per accedere:
- Studenti dell'Università di Trieste: utilizzare le credenziali di ateneo (senza @ds.units.it)
- Nuovi studenti: se dopo il primo login vi è chiesto di impostare l'indirizzo email, ricordate che s12345@ds.units.it non è un indirizzo email ma il vostro nome utente
- Docenti e personale dell'Università di Trieste: utilizzare la propria matricola (senza alcun dominio, ad es. @ds.units.it)
- Membri di altre Università ed enti (appartenenti all'Alleanza T4E e Federazione Idem): accedere tramite T4EU & IDEM login